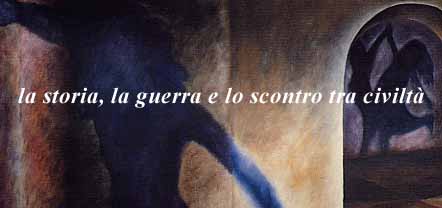Cronache di Manhattan
II
|
L'iconografia di questo articolo è tratta dal
ciclo di opere pittoriche "le tauromachie" di Michele Cannaò messe
gentilmente a disposizione di Storia in network
dall'autore |
Terrorismo batteriologico
e intossicazione mediatica - La guerra, il fronte, le prime vittorie -
Il fantasma dell'alterità e lo scontro tra civiltà - Dal medioevo
senza ritorno -
Rinascite, riforme, rivoluzione…
metamorfosi

Il direttore di Storia in Network mi comunica che le "le
cronache di Manhattan" pubblicate ne La cattedra hanno registrato un
considerevole interesse da parte dei lettori della nostra rivista; ne ho
personalmente un effettivo e positivo riscontro in seguito alle visite sul
sito lastoria.org. Ringrazio i lettori e ne concludo che storia e
attualità, tempo breve e narrazione istantanea, cronaca e comunicazione
hanno ormai valicato i loro reciproci confini in una sorta di
globalizzazione governata dai media (cioè eterodiretta) che predefinsce in
modo rigoroso ogni nostro consumo e l'insieme delle ragioni stesse del
comunicare; predefinisce i contenuti, le emozioni, la trama stessa di ogni
possibile racconto. La storia si scrive "qui e ora", di minuto in minuto,
di comunicato in comunicato, di servizio in servizio, di articolo in
articolo (anche su questa rivista) in una sorta di battaglia campale (che
è forse la vera guerra di questo nuovo secolo) tra eventi in lotta per la
loro momentanea quanto casuale sopravvivenza. Come sottrarsi all'Evento
che domina a tutto campo il sistema della comunicazione storica e
politica: la guerra mondiale del XXI secolo? L'onda d'urto della guerra in
Afghanistan non si è ancora spento; anzi, nuove varianti, nuovi eventi
nell'Evento, tengono in vita e gonfiano oltre ogni misura quello che deve
essere il punto di partenza della storia di tutto un secolo. A farsi
prendere dalla tempesta mediatica in atto che confonde fatti veri e
immaginazione creativa, propaganda e analisi politica, cronaca spicciola e
ricerca storica, si ha l'impressione che ciò di cui stiamo, volenti o
nolenti, parlando non è del nostro presente, ma del nostro futuro: le
origini dell'Evento appaiono a tutti irrilevanti rispetto ai suoi esiti
futuri. La storia ha invertito il suo corso, ci incalza e va ormai dal
presente al futuro. Come resistere a questa deriva? Quale altra storia
scrivere se non quella che tutte le mattine del mondo si mette in moto a
partire dai media e che tutto assorbe (storia antica, moderna
contemporanea, storia del futuro) in una storia magari istantanea, ma
davvero universale?
I lettori mi scuseranno dunque se ritorno al mio
diario interrotto il 26 settembre (una data ormai remota vista
l'accelerazione e l'inflazione degli eventi) per riproporre alcune
riflessioni nella speranza di uscire dal coro, di offrire una pausa, di
andare magari un poco più in là…
Nell'affrontare questo tema ormai
inflazionato, chi vive in Italia perlomeno un vantaggio ce l'ha. Privo di
una reale politica estera (se non quella ovvia di una passiva fedeltà
Atlantica e di una ipocrita vocazione europea), eccentrico rispetto
all'Europa, impegnato in una incerta (e frustrata) politica mediterranea e
filoaraba che non si è mai realizzata, dotato di una classe politica
mediocre ma loquace fino allo schiamazzo, l'Italia, ancor più di altri
paesi, di questa guerra sa poco o niente. In generale nessuno ne sa
naiente (il governo USA a imposto una rigorosa censura e comprato tutti i
diritti delle emittenti sull'Afghanistan), ma almeno noi sappiamo anche di
non saperlo. Sappiamo che tutto ci passa sopra la testa come da secoli,
poco o nulla ci coinvolge e sconvolge: senza troppe tragedie aspettiamo
che la nottata passi.
Come uscire dalla ossessione mediatica che al
pari della droga crea assuefazione, intossicazione e poi progressiva
narcosi? Che dire , che fare dunque per spezzare la spirale dell'attualità
e vincere la velocità del tempo dell'informazione "a perdere"? Gli
argomenti naturalmente non mancano. Proviamo a parlarne insieme, a
ragionarci su.

Concludevo le mie riflessioni nel precedente articolo con
la considerazione che con questo Evento (molto più che una guerra) abbiamo
davvero voltato pagina, cambiato secolo. Avanzavo inoltre l'ipotesi che
Bush, al pari di Gorbaciov, si presentava e si presenta come il
liquidatore della potenza americana nel "mondo nuovo" e nel nuovo secolo.
I fatti, per come vengono raccontati, mi sembra che confermino questa
intuizione.
La guerra adesso c'è ormai da un mese. Operazione di
pulizia, bombardamenti, mobilitazione delle alleanze, formidabile campagna
di stampa e propaganda, investimenti, inquietudine generale, stato di
crisi e ristagno economico (economia di guerra), accaparratori e
speculatori, servizi segreti in azione, innocenti che muoiono, eroi che
non nascono. E' una guerra vera del "mondo nuovo" come quelle in Iraq e
Iugoslavia (e molte altre che non hanno fatto audience in questi ultimi
tre decenni di preparazione dell'Evento finale) e anche il suo esito può
sembrare scontato. Un nuovo governo (che è in corso di preparazione a
livello internazionale), sostituirà quello Telebano, farà le sue purghe e
darà il via all'inevitabile processo di ricostruzione (modernizzazione e
democratizzazione) cioè gestirà i fondi per lo sviluppo-risarcimento con
l'immancabile ausilio di banche svizzere e paradisi fiscali. O almeno così
si auspica. Questa procedura però qualche significativa variante la offre
rispetto ai clichet precedenti: in primo luogo l'Alleanza del nord (che
ricorda molto il Deserto dei tartari del nostro Buzzati) non è un
movimento di popolo (o di classi e ceti sociali), ma una insieme di gruppi
tribali e di etnie tra loro in concorrenza; in secondo luogo la base del
nuovo assetto politico dovrebbe essere offerta dal ripristino di una
millenaria assemblea tribale (una sorta di Stati generali senza stati, di
dieta medioevale senza rappresentanti degli ordini) moderata da un monarca
(84 anni!) in esilio da circa trenta. Siamo molti lontani dai canoni e dai
paradigmi della storia europea e moderna; precedenti non ce ne sono in
questo processo storico che i media e gli storici cercano di
interpretare.
Anche il fronte di questa guerra è davvero inedito
rispetto ai modelli del più recente passato e di tutto il passato.
Dichiarata contro il "terrorismo internazionale" (che però non si riesce a
definire né concettualmente, né politologicamente) questa guerra
planetaria segna il prevalere del fronte interno su quello esterno. Negli
USA, sconvolti dalla minaccia dell'antrace e dalla caccia ai terroristi,
sta passando una legislazione sulla sicurezza e sul controllo che è
palesemente in contrasto con la tradizione culturale del paese; in Europa
si manifesta una corrente bellicista che, se non prelude al riarmo, è
certo alternativa alle opzioni di sviluppo politico e democratico
dell'Unione; in Medio oriente si è aperto un fronte interno terrorista tra
Ebrei e Palestinesi che l'ordine mondiale non è più in grado di
controllare e che mette in crisi gli equilibri stessi dell'alleanza e
delle "forze del bene"; in Asia (Pakistan, India, Malesia, Cina persino)
questa guerra la si sta già combattendo più sul fronte interno che su
quello esterno. Questi elementi di novità divengono addirittura
sorprendenti se si mette in conto il fatto che questa guerra mondiale ha
identificato il suo nemico in una banda di circa tredicimila psicopatici
al soldo di un miliardario clandestino. Del nemico sappiamo ormai tutto
(almeno così ci si fa credere): consistenza, dislocazione, armamenti,
finanziamenti, tipo di addestramento e tattica; sappiamo insomma quanto
basta per sapere che la sistematica distruzione di Kabul e di altre città
(in realtà già cumuli di macerie prima ancora di essere bombardati),
l'eventuale infiltrazione di corpi speciali, la distribuzione via etere di
pranzi preconfezionati e protesi ortopediche, non hanno nulla a che vedere
con la tipologia della guerra tradizionale. I primi ad affermarlo sono i
militari che ora denunciano la imprevista novità dell'evento,
l'impreparazione e l'inadeguatezza dei mezzi e delle vecchie opzioni
strategiche. Il fronte è invisibile, il nemico improbabile e la sua
rappresentazione in termini di media, di racconto appare impossibile (si
direbbe quasi che ce lo siamo inventato).
Probabilmente è una guerra
di spie, infiltrati, voltagabbana, ricattatori, insomma una guerra tra
organizzazioni (criminali) burocratiche di modello aziendale.
Probabilmente tutto quello che sta accadendo e un casus belli per la
redistribuzione del potere mondiale tra nuovi soggetti. Probabilmente… Ma
su questo punto torneremo dopo, per ora quello su cui val la pena di
riflettere è che proprio questa inquietudine generale, questo clima di
confusa incertezza nei giudizi e nelle procedure da seguire dilata il
fronte interno sino al nostro fronte interiore, sin dentro di noi, nel
profondo della nostra coscienza. I perché aumentano, i dubbi anche, la
diffidenza verso ogni tipo di informazione viene vinta solo da uno stadio
di crescente narcosi e intossicazione mediatica.
Comunque sia, alla
luce di questi elementi di novità le prime vittorie, è doloroso dirlo,
vanno attribuite al nemico. Credo che su questo e a questo punto del
racconto possiamo essere tutti d'accordo. In primo luogo OLB (come bin
Laden viene burocraticamente chiamato in codice) e i suoi hanno conseguito
e mantengono una audience "storica": si parla e si scrive più di loro di
quanto si sia mai fatto di un miracolo, di una grande scoperta
scientifica, di un nuovo detersivo o modello automobilistico. Tutto il
mondo deve confrontarsi con loro: abbiamo dovuto ascoltarli e siamo
costretti a subirli quotidianamente; e c'è da augurarsi che altre
minoranze ideologico-religiose o etniche o politiche non ne seguano
l'esempio per conquistare il sistema delle comunicazioni mondiali con
nuovi colpi di mano. In secondo luogo un nucleo sparuto di criminali, un
capitano di ventura e una banda di mercenari hanno suscitato, non già una
operazione di polizia, ma una vera guerra mondiale e messo in crisi
l'assetto di potere degli Stati Uniti d'America. Vengono poi giudicati
responsabili della recessione mondiale e, sul piano militare, sono
tutt'altro che sconfitti: per ora non hanno perso una battaglia perché
ancora non si è combattuto, ma l'ipotesi di una cattura di OLB e dei
vertici della sua organizzazione pare accantonata. Infine, quel che più
conta, i Talebani hanno raccolto e stanno raccogliendo consensi nel mondo
(e non solo quello islamico) e tentano di candidarsi come tutori degli
oppressi del "mondo nuovo". Se vi è un dispiegarsi di alleanze contro OLB
vi è anche un moto, forse appena visibile ma non meno importante, verso un
mondo antidiluviano e tenebroso che si regge solo sulla forza di una cieca
intolleranza paranoidea. Insomma per ora questi nemici-fantasma stanno
scrivendo la storia, la nostra storia. Sono loro che tengono banco. E c'è
di più, molto di più.
Non solo i nostri media hanno dovuto prendere atto, e
quotidianamente ce lo mostrano, che questa guerra è anche e forse
soprattutto il sintomo della nostre contraddizioni e di una politica
improvvisata quanto brutale dei paesi sviluppati (Bin Laden lo hanno
inventato, finanziato e supportato gli USA) per un governo esclusivo del
mondo, ma la nostra informazione culturale e la nostra stessa cultura di
massa ha preso atto, al di là delle semplificazioni mediatiche, che vi è
forse una alterità all'uomo occidentale e al cittadino-consumatore, che vi
è o vi può essere un tipo di socialità diversa da quella
dell'intrattenimento mediatico, delle vacanze in paesi esotici e dei
centri commerciali cari alla prosa e all'inventiva di Saramago. Che sotto
la narcosi della rivoluzione informatica e del mercato dell'informazione
cova e può "rinascere" qualcosa di nuovo, diverso, alternativo che ha il
sapore della "rivoluzione". Per ora lo abbiamo chiamato Islam e ciò ha
dato vita a una stagione di informazione culturale sulla religione di
Maometto, sulla tradizione del sapere islamico, sulla geografia politica e
morale di circa ottocento milioni di abitatori del pianeta, ma ha anche
aperto il varco a una semplicistica quanto pericolosa interpretazione
dell'Evento.
Questa guerra senza fronte, senza confini, senza popoli e
nazioni, senza bandiere, inni eroi e medaglie, senza nemici credibili (che
forse dovremmo ricercare dentro di noi o nelle contraddizioni del nostro
sistema), questa guerra che sarà lunga e che per ora stiamo perdendo ha
ingenerato per un attimo come chiave interpretativa quella di uno scontro
tra civiltà: la civiltà dell'Islam da un lato e dall'atro… ma questo
ancora non ci è dato saperlo. Si tratta di un modello interpretativo
dell'Evento del tutto fuorviante, regressivo e difficile da fondare sia
storicamente che politicamente (dunque moralmente). L'idea di un confronto
tra civiltà (che in mancanza di meglio potrebbe anche far presa) è infatti
di per se più fondamentalista del fondamentalismo islamico, non ha nulla
di laico, nulla di scientifico e riporta in vita una concezione della
storia di marchio ottocentesco che, al pari del nazionalismo, ha fatto il
suo tempo (e disastri consistenti).
Oggi, nel mondo nuovo del XXI
secolo, non esistono più sistemi (o modelli o blocchi) di civiltà tra loro
in competizione; quel che esiste semmai e un crescente pluralismo
culturale in seno a un'unica civiltà (se così la vogliamo chiamare) e
questa civiltà è quella cosmopolita, della tolleranza, pluralista e aperta
che l'emergere della tecnologia, la mobilità-scambio del pensiero e degli
esseri umani e la globalizzazione hanno generato e al tempo stesso
minacciano. Questa civiltà, intuita e per certi aspetti inventata dalla
cultura europea del XVIII secolo, non è né occidentale né orientale, né
islamica né cristiana, né strutturalmente democratica né strutturalmente
teocratica. Semplicemente è un processo di laicizzazione forzato, di
modernizzazione irreversibile che pone agli esseri umani il problema di
una coabitazione non solo tra loro, ma anche con i mezzi di distruzione
(materiale e morale) che la tecnologia genera e che gli esseri umani non
mostrano di saper governare. Questi mezzi di distruzione e autodistruzione
non sono solo gli arsenali nucleari o il monopolio delle informazioni
(quindi la possibilità della loro manipolazione), ma anche e soprattutto
la corsa sfrenata al potere di sfruttamento-distruzione delle risorse
umane e naturali, il divario e le molteplici velocità dello sviluppo, il
progressivo deperimento dei poteri locali, la crisi dell'organizzazione
statuale, il prepotente emergere di poteri sovranazionali e multinazionali
liberi da ogni controllo e, in defintiva, estranei alla legalità dalla
quale ci sentivamo tutelati e protetti. Dunque più che di uno scontro tra
civiltà questo evento sembra lasciarci intravedere una alterità, un che di
nuovo (ma anche ignoto) e di diverso ( ma per certi aspetti
rivoluzionario) con cui misuraci a partire proprio dal nostro fronte
interno.
Quella che rischia di essere la clamorosa vittoria di OLB è il
monopolio di una alterità al sistema mondiale così come è (incapace di
autoregolarsi) e cioè quello di una offerta "politico-ideologica", una
offerta di miti e mitologie antisistema vincente sul vasto mercato delle
emozioni e delle aspettative di emancipazione e di vita. In questo caso il
fondamentalismo in tutte le sue varianti, lungi dall'essere un fenomeno
residuale, un rigurgito del passato remoto, sarebbe un che di
assolutamente innovativo e come tale del tutto concorrente ai residuali di
una cultura della modernità in pieno declino.

Ma l'idea dello scontro di civiltà non è solo peregrina,
è anche pervicace, fa presa e, anche se smentita sotto il profilo teorico
e semantico, si sta consolidando nei media e nel loro linguaggio; ha
contagiato un po' tutti e reso facile (quanto gracile) la propaganda di
guerra e l'interpretazione dell'Evento. Quello a cui assistiamo è
l'insorgere di un linguaggio e un insieme di metafore regressive e
vagamente medievali. Si è partiti da "giustizia infinita", ma non ci siè
fermati a "giustizia durevole". "Civiltà" e "barbarie", "guerra giusta" e
"guerra santa", "forze del bene" contro quelle del "male", "punizione" e
"giusta vendetta", "difesa della civiltà" e "operazione di giustizia
internazionale", "solidarietà con il popolo americano" e "nazione ferità",
"missione umanitaria" e "missione di civilizzazione" da un lato;
dall'altro "infedeli" e "satanici", "ricchi" e dunque "colpevoli", "atei"
e pertanto "peccatori", "fratellanza islamica" e "martiri". Sono questi i
mattoni di un sintassi non già della curva nord di San Siro o di ultrà dei
ghetti urbani, ma di capi di stato, analisti, politologi, esperti di
strategia, persino uomini di cultura. Un festival generalizzato
dell'intolleranza e della incultura politica che rischia di trasformare
questo evento così drammatico in un intrattenimento (si fa per dire) da
piazza e di celarne la vera portata ai nostri occhi. Si tratta di un
convoglio semantico che sembra prendere il via dal medioevo senza altra
meta che farvi ritorno. E' una miscela di droghe pesanti, un confronto a
tutto campo tra modelli di cultura primordiali e rozzi che deprime e
scoraggia ogni tentativo di analisi.
Per questo tramite comunicativo
si istituisce così una sorta di schizzofrenia narrativa di questa storia
istantanea e quotidiana tra il livello tecnologico, freddo, e quello
mitico, passionale ed emotivo. Da un lato l'immaginario di sofisticati e
innovativi (quindi per definizioni positivi e vincenti) strumenti di
guerra e dall'altro la violenza pura senza freni inobitori che la guerra
stessa suscita e legittima. L' "operazione chirurgica" dei bombardamenti
(che appunto per essere tale colpisce anche ospedali e Crocerossa) e le
manifestazioni di piazza, cioè televisive, giornalistiche. Quel che
preoccupa è che questo modello elementare di propaganda, con i suoi slogan
stereotipi e vagamente irresponsabili, lascia intravedere una mancanza di
controllo, di ordine mentale: si procede a tentoni, al buio, ancorati a un
incerto passato e a una incerta identità, con un linguaggio a buon mercato
e una cultura politica che è giunta a un assai basso grado di temperatura
morale. Proprio in presenza di questa rievocazione medioevale delle
emozioni politiche, Bin Laden rischia di fare storia davvero, di scrivere
lui la nostra storia. Com'è che siamo arrivati a questo punto? Perché il
passato non ci insegna nulla di meglio? E come mai è così difficile
trovare nei paradigmi della storia fonte di ispirazione per interpretare e
governare gli eventi del presente?
Perché forse è proprio la storia
intesa come maestra di vita, come arsenale dell'esperienza umana, che in
questo nuovo assetto di civiltà fatta di molte culture destinate a
convivere, appare una risorsa troppo fragile e perché forse, come dicevo
all'inizio, essa ha invertito il suo corso e marcia dal presente al futuro
lasciandoci orfani dei modelli e degli insegnamenti di tutto il nostro
passato. Rispetto alla accelerazione e alla compressione del tempo di
questo XXI secolo e a fronte del diritto di cittadinanza di una pluralità
di culture questa grande invenzione della cultura occidentale che è stato
il motore e l'interprete della modernità ha forse fatto il suo tempo.
Ecco qua: siamo arrivati forse al punto di fuga, alla via
d'uscita dalla tempesta mediatica e della intossicazione dell'informazione
"a perdere".
Solo a partire da questo insieme di considerazioni, mi
infatti pare possibile, in quanto appassionato storia e storico,
abbandonare l'emergenza dell'attualità e della contemporaneità per
ricondurre l'evento della guerra del XXI secolo a un ciclo più lungo e a
orizzonti più dilatati nel tempo. Prendendo spunto da queste riflessioni e
dalle domande in merito che lettori e studenti mi rivolgono, ho deciso di
affrontare, nel corso di quest'anno, il tema dei paradigmi di
interpretazione del mutamento storico che la cultura europea ha messo a
punto nei secoli della modernità. Chi lo sa se questa procedura può
offrire qualche chiave interpretativa "forte" alle vicende in corso?
Comunque sia, proprio questo testo si configura come la lezione
introduttiva di tutto un ciclo di lezioni per l'anno accademico in corso.
La funzione stessa della nostra Cattedra di Storia in Network è pienamente
rispettata, e spero con soddisfazione del Direttore.

Mi sono chiesto se, per spiegare questi eventi politici
nella loro proclamata dimensione planetaria, l'esperienza storica della
modernità possa essere di qualche aiuto.
Rinascita, riforme e
rivoluzione (questo l'argomento del corso che sto mettendo a fuoco anche
grazie all'esercizio al quale mi induce la Cattedra di Storia in network)
sono i paradigmi interpretativi del mutamento storico elaborati dalla
cultura occidentale nei secoli della modernità (XIV-XIX). Divenuti
metafore "forti" e universalmente diffuse, questi paradigmi sono penetrati
nel linguaggio comune e nel sentire diffuso sino a costituirsi come
mitologie del pensiero politico e come fondamento delle elaborazioni
teoriche del potere. La storia di queste metafore è antica e per molti
aspetti affascinante.
L'idea di rinascita si connette automaticamente
a quella di morte e alla consapevolezza di un mondo, di una civiltà
scomparsa per sempre (quella antica) dalle cui ceneri può però risorgerne
una nuova dopo una pausa, una vera e propria sospensione-archiviazione del
tempo storico. Il Rinascimento fu appunto la rinascita del tempo e della
politica e coincise con la fondazione delle Stato e di quel potere sovrano
il cui compito era assicurare la giustizia, un giustizia umana e fondata
sull'humanitas oltre e al di sopra delle fedi religiose e delle
appartenenze etniche.
L'idea di riforma, che certo principia
dall'esperienza della Riforma luterana e cioè dalla lotta per una
modernizzazione e adeguamento del credo e delle pratiche religiose europee
alle mutate esigenze del quadro economico e sociale dei secoli XVI e XVII,
è divenuta dominante nel corso del XVIII secolo e ha proclamato la
definitva laicizzazione della politica. Gli uomini del Settecento
ritenevano infatti che il potere, sovrano e assoluto, dovesse assicurare
non solo ordine e giustizia, ma addirittura felicità ai sudditi e che lo
stato fosse un agile strumento in grado di rimodellarsi sulle esigenze
nuove poste dal moto progressivo della storia. E il secolo dei Lumi fu
appunto il secolo delle riforme e della grande modernità.
Infine
l'idea di rivoluzione, originariamente desunta dal linguaggio astronomico,
ha rappresentato un nuovo modo di percepire il mutamento storico e
governarlo: un moto tale da consentire agli degli umani di por mano alla
costruzione del proprio futuro mediante rotture radicali e violente con
tutti pesi del passato. L'obiettivo del potere e dello stato veniva così
fissato non solo nella giustizia e nella necessità di assicurare felicità
ai conviventi sotto una unica legge comune, ma soprattutto di garantire ad
ogni cittadino il diritto di partecipare alla costruzione e al governo
della società futura in una condizione di parità e di eguaglianza e senza
mediazioni: la cittadinanza. Lo stato poteva così assumersi il compito di
garantire anche lo sviluppo morale e materiale dei suoi cittadini.
Ora,
in questo lungo percorso di tempo che è la nostra storia e la storia della
modernità, rinascita, riforma e rivoluzione hanno rappresentato i modelli
del mutamento storico e segnato le varie velocità del tempo, lo hanno
messo in moto e ne hanno fissato i ritmi per poterlo governare. Però pure
nelle sostanziali diversità di queste metafore e di questi ritmi, lo scopo
del correre del tempo e l'obiettivo finale della storia, è sempre stato
quello di una civiltà cosmopolita fondata sulla pace (dunque la
tolleranza) e sulla fratellanza universale (dunque sulla pluralità delle
culture). Il pensiero e il sentire politico della modernità erano e sono
alla continua ricerca di un paradiso di quaggiù e non di lassù. Per questo
gli eroi e i martiri della nostra storia sono profondamente umani. Per
questo e non per altro la modernità si è imposta come un modello
efficiente di civiltà. E oggi è ancora possibile utilizzare questi
paradigmi per interpretare e governare il corso del tempo?
L'emergenza
tecnologica che caratterizza il XX secolo, il profondo mutamento nel
sistema delle comunicazioni umane per effetto dell'accesso alla rete che
segna l'avvio del XXI secolo e i processi di integrazione-globalizzazione
culturale che ne conseguono, paiono aver archiviato l'uso di queste
classiche metafore e propongono interessanti interrogativi.
E'
possibile immaginare una rinascita dell'uomo in un'epoca nella quale
l'uomo stesso sembra essere un prodotto della manipolazione tecnologica?
Quali riforme sono praticabili in una società che assume l'innovazione
tecnologica, con i suoi ritmi sempre più accelerati e ingovernabili, come
un evento naturale e dunque come un canone dell'ordine e della stabilità?
L'idea di una rivoluzione, intesa come rottura violenta e consapevole
dell'ordine politico e sociale per la costruzione di un mondo migliore, è
praticabile in una civiltà che dispone di sistemi di controllo e
repressivi tanto possenti quanto universali? In presenza della crisi da
tempo proclamata delle ideologie (e dei valori) quale ruolo compete, nel
"mondo nuovo" del XXI secolo, al pensiero e all'impegno politico? E
infine, per quanto ci riguarda, a quale modello iscrivere l'insieme di
vicende che a partire da ciò che accade in Afghanistn stanno cambiando il
volto del mondo?
La paradossale situazione di questa guerra tutta nuova
del XXI secolo, la difficoltà di ricorrere all'arsenale concettuale posto
in essere dalla modernità per interpretarla e governarla, mi lascino
intendere che forse il nostro tempo è quello non delle rinascite, delle
riforme e delle rivoluzioni, ma di grandi, misteriose metamorfosi, di
mutamenti istantanei, inattesi, casuali, fantastici (anche mostruosi).
Insomma abbiamo davvero voltato pagina e la storia ci impone nuove sfide,
nuove affascinanti avventure.